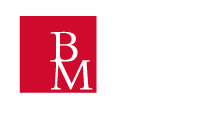A preoccupare gli autori fin dall'epoca del primo diffondersi della stampa è stato il problema della copertura delle spese necessarie alla pubblicazione dei loro testi; e quand'anche fossero stati tipografi ed editori a sostenere i costi, i letterati perseguivano comunque la ricerca del legittimo compenso delle loro fatiche, che poteva realizzarsi in una remunerazione concessa dal patrono o in un quantitativo di copie personali fornite dallo stampatore.
Fatte salve rare eccezioni, la vicenda dell'autore italiano si snoda per l'intera epoca dell'antico regime attraverso continue difficoltà, frapposte alla dichiarazione della sua autonomia intellettuale ed economica da parte di tipografi poco disposti a rischiare del proprio, di mecenati spesso avari ed insensibili, e di un mercato di lettori-acquirenti cronicamente insufficiente.
Il Settecento è il secolo dove il fenomeno appena evocato può essere monitorato in tutta la Penisola, e dove in controtendenza si possono cogliere moderne istanze destinate ad emergere chiaramente nel secolo successivo, quali l'affermazione della proprietà letteraria e della professione di autore, nonché l'esigenza di un pubblico più largo e differenziato.
La condizione dell'autore italiano settecentesco è indagata fin dalle pratiche di raccolta del materiale e di organizzazione del lavoro che precedono la consegna del manoscritto allo stampatore. Ad essere ricostruita, con il ricorso a documentazione inedita, è poi la prassi consolidata dell'anticipo di spese tipografiche, da recuperarsi a stampa ultimata grazie al sistema delle dediche.
L'intervento di mecenati e committenti (questi ultimi interessati alla produzione di uno specifico testo) consente tuttavia a letterati e uomini di scienza di dedicarsi alla redazione delle proprie opere con sufficiente tranquillità, certi dell'esito editoriale, pur nei limiti, economici e sociali, del variegato panorama del patronage italiano. L'autore dovrà allora difendersi dalle ristampe abusive che rischiano di taglieggiare i risicati profitti della vendita delle copie di sua spettanza; ma per colui che subisce la pirateria editoriale vi è la conferma della fortuna dei suoi scritti e del credito goduto.
Così il volume si conclude con l'analisi del tema del successo e della percezione che di esso si aveva nella comunità dei letterati, fino a delineare i confini del più riposto obbiettivo di chi aveva abbracciato l'esercizio della penna, vale a dire il conseguimento della gloria.
Marco Paoli
Direttore dell'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha esordito con studi di storia della miniatura, da cui il suo primo volume monografico (I corali della Biblioteca Statale di Lucca, Firenze, Olschki, 1977) e numerosi saggi apparsi negli atti dei congressi internazionali di Cortona o in importanti riviste italiane e straniere ("La Bibliofilia", "Gutenberg-Jahrbuch", "Critica d'arte").
A tale indirizzo di studi appartiene, più recentemente, anche il volume I codici di Cesare e Giacomo Lucchesini. Un esempio di raffinato collezionismo tra Settecento e Ottocento (Lucca, Pacini Fazzi 1994).
Contemporaneamente ha avviato una serie di ricerche di argomento storico-artistico, culminata nel volume Arte e committenza privata a Lucca nel Trecento e nel Quattrocento (Lucca, Pacini Fazzi 1986), condotto su inedite fonti figurative e documentarie, in un momento in cui risultavano rari i contributi alla storia del mecenatismo artistico italiano.
Nel 1999 ha dedicato uno studio al celebre monumento di Ilaria del Carretto. Ai suoi interessi per la storia del libro a stampa e più generalmente per il fenomeno editoriale si devono il catalogo in due volumi degli Incunaboli della Biblioteca Statale di Lucca, la collaborazione al Dizionario dei tipografi e degli editori italiani (Milano,Editrice Bibliografica 1997), e la fondazione e la direzione, nel 1994, della rivista "Rara Volumina", giunta, con i tipi di Pacini Fazzi, al suo decimo anno di vita: ivi ha pubblicato articoli sulla ritrattistica di Ugo Foscolo, su Galileo Galilei e il pubblico, e sull'editoria archeologica settecentesca, testo di una sua conferenza al Museo del Louvre nel 2001.
Nel 2002 ha curato il saggio introduttivo in occasione della ristampa degli Statuti cinquecenteschi della Corte dei Mercanti di Lucca (Roma, Senato della Repubblica). Ha in preparazione un volume sull'edizione lucchese dell'Encyclopédie di Diderot e D'Alembert, del cui apparato iconografico si è precedentemente occupato (2002).
MARIA PACINI FAZZI EDITORE s.r.l.,
Via dell'angelo custode, 33 c.p. 394 - 55100 Lucca, Italia
tel. +39 0583 440188 - fax +39 0583 46.46.56, c.c.postale 11829553,
http://www.pacinifazzi.it, e-mail: mpf@pacinifazzi.it